Il Rapporto Camera dei Deputati-Cresme sulla riqualificazione edilizia evidenzia la spesa incentivata di 51,2 miliardi di euro per il 2021.
Il Servizio Studi della Camera dei Deputati, in collaborazione con l’Istituto di ricerca Cresme, ha pubblicato nei giorni scorsi un’anticipazione a stralcio del Rapporto sulla riqualificazione edilizia nel 2021.
Questo Rapporto contiene, tra l’altro, una stima dell’impatto delle misure di incentivazione che, in varie forme, forniscono spinta agli investimenti per la riqualificazione degli immobili.
La riqualificazione incentivata nel 2021: 51,2 miliardi di spesa
Il Rapporto Camera-Cresme sottolinea anzitutto i vari fattori che concorrono alla dinamica di crescita della spesa per investimenti in riqualificazione edilizia:
- la crescente domanda di manutenzione degli immobili, dovuta sia al deperimento naturale che a nuove esigenze abitative;
- la cultura conservativa del patrimonio storico che caratterizza il nostro Paese;
- negli ultimi venticinque anni gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio sono stati sostenuti dall’introduzione di misure incentivanti e dal loro potenziamento.
Nel Rapporto viene evidenziato, in particolare, ciò che è accaduto a partire dal 2020, vale a dire:
- l’introduzione del bonus facciate;
- con la pandemia e i relativi periodi di lockdown l’osservazione delle proprie abitazioni è cresciuta e, con essa, l’insorgenza di nuovi fabbisogni;
- in parallelo, è avvenuta una contrazione dei consumi e una maggiore propensione al risparmio;
- l’introduzione del superbonus del 110% e le successive misure atte a semplificarlo.
Secondo le stime del Cresme, gli investimenti complessivi in riqualificazione edilizia (residenziale e non) nel 2021 arrivano a quasi 100 miliardi di euro: 30 miliardi in più rispetto al 2020 e 24 miliardi in più rispetto al 2019.
I lavori di riqualificazione solo nell’edilizia residenziale, stimati dal Cresme, ammonteranno a fine 2021 a 75 miliardi di euro (25 miliardi oltre il 2020 e 21 miliardi oltre il 2019). Di questi, 51,2 miliardi di euro provengono dalla riqualificazione incentivata. Queste cifre, precisa il Rapporto, si basano su un percorso estimativo per la mancanza di alcuni dati certi, visto che, in particolare la cessione del credito e lo sconto in fattura, può non essere previsto il cosiddetto bonifico parlante.
L’impatto del superbonus
Il Rapporto, citando le rilevazioni compiute da Enea e dal Ministero dello Sviluppo Economico e poi dal Ministero della Transizione Ecologica, riporta i dati al 31 ottobre 2021 in base ai quali c’è un consuntivo di 57.664 interventi, per un ammontare dei lavori di progetto pari a 9,74 miliardi di euro. Pertanto, l’ammontare della detrazione spettante (spesa pubblica) è di 10.715 milioni di euro.
Sempre con aggiornamento risalente a fine ottobre 2021, gli interventi di super ecobonus risultano a progetto per:
- 8.356 edifici condominiali, con un importo complessivo di 4.793 milioni di euro, pari a 574mila euro ad edificio;
- 49.307 edifici unifamiliari e unità indipendenti, con un importo di 4.948 milioni di euro, pari a 100mila euro a fabbricato.
Per quanto riguarda i tempi di ritorno (payback) della spesa pubblica (il 110% del valore degli investimenti), nel Rapporto si afferma che avremmo delle durate che sarebbero insostenibili da parte di qualunque investitore privato. Si tratta infatti di 68 anni per recuperare la spesa degli interventi trainanti sull’involucro e 56 anni per gli interventi (non impianti) trainati sulle singole unità immobiliari. In altre parole, quando il risparmio energetico accumulato negli anni ci permette di recuperare il denaro speso, il nostro involucro edilizio avrà, probabilmente, esaurito la sua vita tecnica utile. Lo stesso ragionamento è per gli infissi, le coperture e gli impianti interni alle abitazioni.
Rapportando gli interventi allo stock edilizio esistente, nella proiezione a fine 2021, con 11,6 miliardi di spesa pubblica, il Super Ecobonus sta intervenendo sullo 0,42% della superficie complessiva degli edifici residenziali esistenti.
Tra l’altro, con 11,6 miliardi di euro di spesa pubblica (sempre nella proiezione al 31 dicembre 2021), il risparmio energetico complessivo dichiarato, trasformato in tonnellate di petrolio equivalente, è di 0,20 MTep/anno. L’obiettivo attualmente previsto dal PNIEC era di 0,33 Mtep/annui, quindi, con il superbonus prolungato ai prossimi anni, con tutta probabilità si potrebbe superare questo target.
L’impatto sull’occupazione
Le stime degli investimenti attivati attraverso gli incentivi, nel periodo 2011-2021, hanno generato un assorbimento cumulato di poco più di 3 milioni di occupati diretti, per una media annua di 281.180 occupati. La media annua, tenendo conto anche dell’indotto delle costruzioni, salirebbe a 421.770 occupati.
Le stime del Cresme evidenziano, inoltre, che l’incremento delle aliquote incentivanti ha comportato una crescita degli interventi di recupero e riqualificazione che hanno operato in trasparenza, portando al 68%, nel 2021, la quota della spesa incentivata nel mercato della riqualificazione residenziale.
L’impatto economico-finanziario degli incentivi fiscali
L’impatto sul sistema Paese è stato descritto nel Rapporto, derivante anch’esso da molteplici e complessi calcoli.
Riassumendo quelli che sono a mio avviso i dati principali, si evincono diversi risultati:
- lo Stato presenta un saldo negativo di 21,4 miliardi di euro, che deriva dall’incremento del gettito (positivo), dai flussi derivanti dalle detrazioni (negativi), dalle maggiori entrate derivanti dalla matrice di contabilità sociale (positive) e dal minor gettito fiscale sui consumi energetici (negativo);
- gli investitori (prevalentemente famiglie, anche nelle ristrutturazioni condominiali), hanno un risultato “negativo” di circa 239 miliardi di euro, che è conseguente al saldo tra l’investimento effettuato (negativo), le detrazioni fiscali (positive) e il risparmio sulle bollette energetiche (positivo);
- le imprese e il fattore lavoro vantano un saldo positivo di quasi 297 miliardi di euro, risultato di un fatturato (positivo), nel quale sono compresi i compensi e le retribuzioni per gli occupati delle imprese stesse, nonché le imposte e gli oneri sociali sostenuti dalle imprese e attribuibili agli incentivi fiscali (negativi).
A conti fatti, il saldo del sistema economico del Paese risulterebbe positivo per 36 miliardi di euro (considerando il periodo 1998-2021).
Interessante l’ulteriore annotazione, in seguito a questo dato, per cui nel Rapporto si citano altri aspetti importanti da considerare, ma la cui complessità è molto ampia e, tra questi, si parla della “valorizzazione del patrimonio immobiliare, in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici”.
Restringendo il campo di analisi al periodo 2011-2021, il saldo per il sistema economico del nostro Paese sarebbe positivo per 26 miliardi di euro.
In prospettiva
I dati e i numeri che ho sintetizzato finora fanno emergere un quadro interessante, perché vengono offerti numerosi stimoli per migliorare ulteriormente le agevolazioni fiscali e perché viene citata la valorizzazione immobiliare.
Quest’ultima è sicuramente difficile da far emergere, in quanto complessa da misurare, vista anche l’eterogeneità del patrimonio immobiliare italiano, ma l’assunzione di maggior valore di un immobile riqualificato è a mio avviso certa: va solo ben qualificata e quantificata. Inoltre, la riqualificazione energetica degli immobili riduce anche i rischi creditizi, come puoi leggere nel mio post dedicato.
Visto che siamo a metà dicembre, a breve studierò con attenzione quanto emergerà dalla Legge di Bilancio 2022, in merito all’immobiliare e alle agevolazioni fiscali e, quando sarà terminato l’iter parlamentare, sarà mia cura, come sempre, pubblicarne un articolo qui sul mio blog.
______________________________________________________

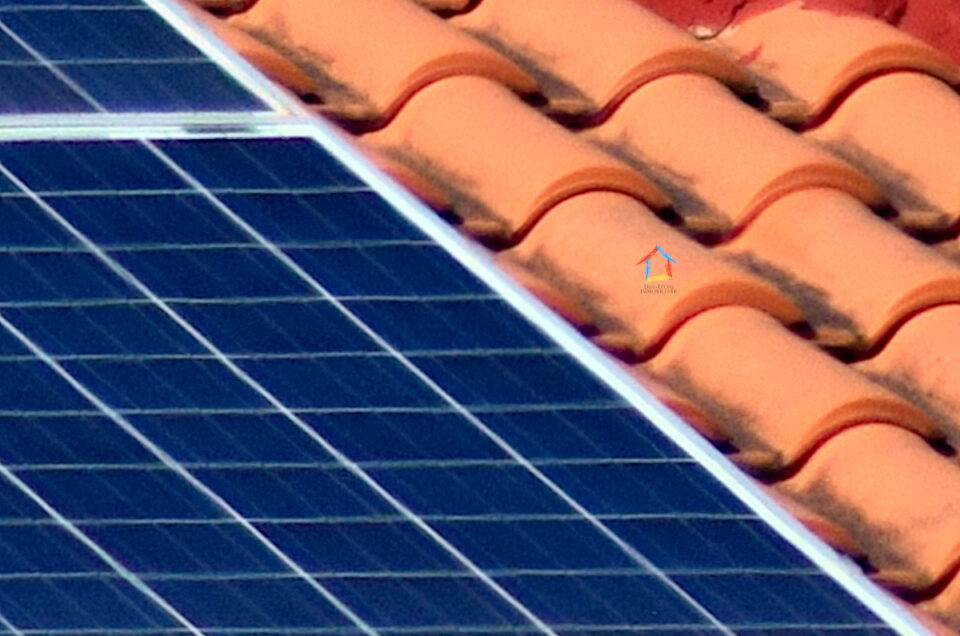









Lascia un commento