Tempo di bilanci e prospettive per la Cooperativa Cecilia Onlus che ha svolto un progetto di assistenza leggera per gli anziani in diversi condomini di Roma.
Svoltosi tra gennaio e luglio 2015, il Servizio di assistenza domiciliare leggera per gli anziani nei condomini è stato portato avanti dallo staff della Cooperativa Cecilia Onlus, a Roma, nella zona Cinecittà – Don Bosco. Il progetto è stato pensato ed elaborato in risposta ad un bando della Regione Lazio, Innova Tu – La nuova sfida dell’innovazione sociale, rivolto a cooperative ed imprese sociali, pubblicato nel 2014 ed i cui obiettivi erano quelli di rispondere in maniera innovativa ai bisogni emergenti delle comunità, valorizzando il ruolo imprenditoriale del mondo no profit.
La Cooperativa Cecilia Onlus, nata nel 1980, ha una lunga esperienza di impegno sociale e oggi – in particolare a Roma nel Municipio VII (ex X) – è impegnata in numerosi servizi rivolti soprattutto ad anziani, disabili e minori.
Il tema dell’incontro tra bisogni sociali e le realtà spesso complicate di alcuni quartieri ha visto in alcune città italiane la nascita e lo sviluppo di iniziative solidali a Bologna, Milano e Modena. Dopo esserne venuto a conoscenza, mi ero riproposto di conoscere eventuali esperienze analoghe nella città di Roma e quindi ho chiesto al dottor Giosuè Pasqua – Responsabile della comunicazione della Cooperativa Cecilia Onlus, che ringrazio vivamente per la collaborazione – di descrivere l’attività svolta a Cinecittà – Don Bosco.
____________________________
Com’è nato il progetto?
L’input è stato dato da un bando della Regione Lazio che si chiamava Innova tu che dava fondi per progetti innovativi e replicabili, come test di possibilità future di servizi per la città. Inoltre, da tanto tempo, come cooperativa Cecilia, portiamo avanti il tema della economia collaborativa, vale a dire risolvere problemi attraverso la mobilitazione della comunità, sia con reti formali (Municipio, parrocchie, cooperative, associazioni, ecc.), sia attraverso reti informali come il vicinato, gli attori di buone prassi locali, la prossimità vera e propria. E pensando anche al coinvolgimento della rete economica, costituita dai commercianti, le farmacie, i laboratori di analisi, le imprese, che possono essere avvantaggiati da un territorio in cui ci sia più benessere sociale, meno degrado e più coesione sociale. Il Municipio è stato nostro partner, abbiamo lavorato sulla lista d’attesa degli anziani. Quindi, la nostra idea è stata di lavorare nei condomini, con un servizio svolto da operatori professionali, assistenti domiciliari o operatori socio sanitari, facendo interventi singoli, dove necessario, per anziani soli e bisognosi, ma anche interventi collettivi, come la spesa o il pagamento delle bollette. In questo modo abbiamo messo in contatto le persone per uno scambio reciproco, partendo da esigenze a volte comuni.
Chi e come è stato raggiunto dal servizio?
Gli anziani hanno usufruito del servizio gratuitamente. Al centro di accoglienza abbiamo avuto più di 400 richieste (perlopiù telefoniche): lì un operatore specializzato ha smistato queste richieste, alcune improprie, e alla fine 307 di queste richieste erano di servizi. Gli anziani che ci hanno contattato non erano già seguiti da altri servizi, quindi abbiamo aggiunto utenza a quella seguita con i servizi canonici. Siamo partiti dalle liste di attesa del servizio per gli anziani, in accordo con i referenti del Municipio, poi si sono aggiunte le più di 300 richieste che dicevo prima. Sono state 26 le persone accolte in assistenza e la maggior parte è stata anche accompagnata a servizi sociali differenti. Fascia d’età media era 70-75 anni e in maggioranza donne. E sono stati 128 gli anziani per cui abbiamo svolto le attività collettive. In totale, abbiamo avuto quindi 461 utenti. Abbiamo operato nel quartiere Cinecittà – Don Bosco, che conta circa 84.000 abitanti, di cui il 22% sono anziani. Noi abbiamo svolto un’assistenza domiciliare leggera, dedicata a persone con parziale autosufficienza, per dare un sostegno, ma a chi ha espresso bisogni maggiori, li abbiamo accompagnati appunto in altri servizi.
In quale arco temporale avete svolto le attività?
Il progetto è stato operativo da gennaio a luglio 2015. Riscontrando il gradimento da parte degli utenti, abbiamo incontrato la Commissione regionale, a fine progetto, e la stessa Commissione continuerà il monitoraggio nella nostra rete territoriale, con gli operatori, con gli utenti, per capire qual è stato l’impatto.
In quanti condomini avete operato e con chi avete avuto rapporti?
I condomini in cui abbiamo operato sono stati 96, incontrando i portieri e le persone che gestiscono la manutenzione condominiale e anche alcuni amministratori. Con i portieri abbiamo avuto un rapporto stabile e abbiamo tenuto con loro un monitoraggio sull’andamento delle attività e, tramite loro, spesso abbiamo compreso la composizione e alcune esigenze per cui abbiamo operato. La loro collaborazione è stata veramente forte. Se riusciremo a proseguire il progetto con la Regione, chiederemo una lettera di presentazione dell’ente agli amministratori. I portieri hanno manifestato dispiacere al termine del progetto, in quanto avevano riscontrato maggior vivacità delle persone coinvolte. Tra l’altro, abbiamo riscontrato che a giugno, quando abbiamo fermato l’accoglienza delle domande, ne stavano arrivando molte più che all’inizio.
Mi potresti descrivere il tipo di intervento che avete svolto?
Abbiamo identificato tre fasce d’assistenza, in base ai nostri servizi e a questo progetto: la fascia dell’assistenza leggera, per quelli che possono farcela con un sostegno, un aiuto; la fascia del servizio domiciliare, in cui le esigenze sono più alte e la fascia delle persone seguite dalle badanti, in maniera più continuativa. Nei condomini, abbiamo fornito assistenza leggera, ma abbiamo anche lavorato come antenne sociali e in alcuni casi abbiamo segnalato le situazioni più gravi. Abbiamo messo in rete i bisogni rilevati. E lavorando in rete abbiamo reso unici gli interventi, aggregando e razionalizzando le varie risorse territoriali, evitando le dispersioni e i doppioni.
Come era composto il vostro staff?
Da tanti anni volevamo fare questo tipo di assistenza qui a Roma, nel nostro contesto. Abbiamo letto delle esperienze portate avanti a Bologna e Milano, poi abbiamo pensato di strutturare il nostro intervento come quello svolto da un operatore di strada, traslato nel contesto condominiale. La nostra equipe è stata formata da 10 persone: 2 assistenti sociali dedicati alla creazione della rete, 2 operatori specializzati per l’accoglienza e 6 operatori domiciliari (in gran parte donne). L’equipe ha cercato e si è creata spazio per nascere, per strutturare l’intervento. Gli operatori si sono resi conto che lavorare in un condominio è stato differente dal tipico lavoro, in rapporto 1 a 1 con gli utenti: in questa attività, si va anche a rilevare i bisogni, anche diversi da quelli solitamente espressi.
Avete incontrato degli ostacoli durante il percorso?
Come dicevo prima, la fiducia, in fase iniziale. E poi c’era la paura che gli facessimo pagare qualcosa, mentre il servizio era stato assolutamente gratuito e quindi lo abbiamo comunicato con sempre maggior chiarezza.
Quali riscontri avete avuto dall’utenza? E ci sarà un futuro per il progetto?
C’è stato un rimpianto generale, a fine progetto, da parte degli utenti e anche da parte nostra. Quindi, abbiamo lasciata attiva una vigilanza telefonica, tramite la nostra assistente sociale. E stiamo portando avanti iniziative per replicare il progetto e le attività. Abbiamo espresso alla regione l’intenzione di non mollare il servizio, perché abbiamo riscontrato una possibilità di futuro, specialmente sulla coesione sociale. Rispetto a quando abbiamo cominciato l’assistenza domiciliare agli anziani nei primi anni ’80, abbiamo notato che sul piano della fiducia c’è stato un notevole calo, negli anni. Nel 1981 tutti aprivano la porta, e in una settimana arrivammo ad assistere 81 anziani in domiciliare. Per la promozione di questo progetto, per rompere la diffidenza, ci abbiamo messo un paio di mesi.
Quindi, come pensate di ripartire?
Stiamo realizzando una lotteria di beneficenza, con cui vorremmo finanziarci con € 10.000 per realizzare la possibilità di mantenere 2/3 interventi a settimana, per creare un ponte, chiedendo alla Regione, nel caso in cui l’assistenza nei condomini fosse ritenuta da loro un vero e proprio servizio sociale, di considerare nuovamente questo progetto, che è stato ritenuto eccellente dalla Regione. Al di là di questo, ci è stato detto che ci sarebbe l’intenzione di rilanciare nuovi bandi nei prossimi mesi. In attesa dei nuovi bandi, che speriamo siano riattivati, dopo la lotteria stiamo lavorando per coinvolgere una fondazione.
Per chiudere, riassumendo, dimmi quale ritieni sia stato il feedback principale espresso dagli anziani coinvolti.
Le persone anziane, finito il progetto, ci hanno comunicato di sentirsi più sole: alla loro porta non bussava più nessuno. E noi comunque, lavorando per loro, abbiamo avuto modo di verificare che quanto ci hanno detto era assolutamente veritiero. “Ho un’unica paura: la solitudine”: questo è ciò che abbiamo ascoltato e per cui abbiamo lavorato. La solitudine, al di là dell’indigenza, che si può combattere meglio, tutto sommato.
____________________________
Le attività svolte e le conseguenti riflessioni offerte da questa intervista pongono al centro il tema della solitudine e delle modalità possibili per combatterla, laddove in una specifica realtà urbanistica emergono bisogni, nuovi di per sé o per cui servono risposte nuove. I cambiamenti in atto nelle città, tra cui senz’altro Roma, stimolano a pensare e ad agire perché il degrado sia diminuito o, per meglio dire, il benessere sia aumentato. Credo sia importante considerare e favorire le potenzialità offerte da progetti e servizi che vanno dentro le realtà, conoscono i bisogni ed agiscono per rispondere ad essi, in maniera capillare e personale. Tutti siamo ormai abbastanza capaci di osservare una realtà partendo dall’analisi di dati, report e quant’altro: può essere una base di partenza, ma poi serve connettere le risorse, personali e materiali. Credo che il progetto descritto sopra abbia avuto questo intento, cioè quello di agire e lasciare traccia allo stesso tempo, perché le buone prassi (ad esempio quella di organizzare al meglio gli interventi nel territorio, evitando il rischio di doppioni o di lacune) riescano a raggiungere la vita reale delle persone. Il fenomeno della solitudine è difficile da combattere, si rileva a fatica e produce disagi anche laddove altri fattori sembrano essere nella norma. Per cui, le forme solidali di intervento che agiscono nei palazzi, nei condomini e nelle case hanno maggior forza e producono benessere nella misura in cui le Istituzioni e i cittadini, il pubblico e il privato, le imprese (profit e non profit) e il volontariato si impegnano per fare una vera rete, tale da ascoltare e rispondere in maniera efficace ai bisogni espressi dalle persone che nei condomini vivono, avendo la speranza di viverci non da soli, ma come parte di una comunità.
____________________________________________



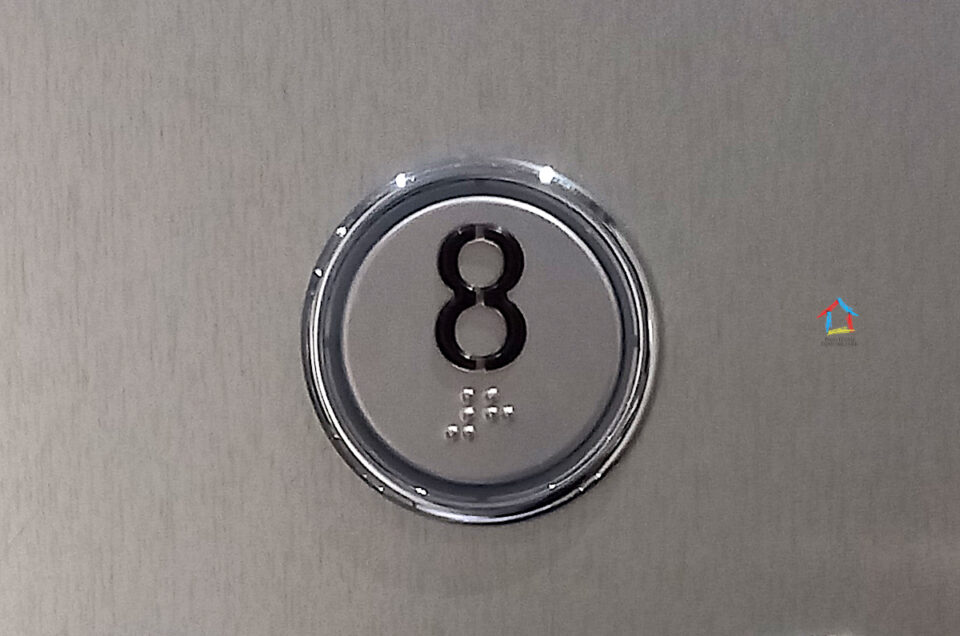







Lascia un commento